Oggi proveremo ad affrontare la seguente questione: in estrema sintesi, cosa sostiene la teoria della complessità?
Se dovessimo riassumere, in pochissime parole, in che cosa consiste la teoria della complessità, probabilmente la prima cosa che dovremmo dire è che la complessità ha due “anime”, un’anima per così dire più scientifica e una più filosofica. Il sociologo Edgar Morin, unanimemente considerato il pioniere e la massima autorità nel campo dell’epistemologia della complessità, parla a questo proposito di due nuclei della complessità: un nucleo empirico e un nucleo logico. Vediamoli uno alla volta.
Partiamo dal nucleo empirico della complessità. Questo primo nucleo, a nostro avviso, è costituito dal margine del caos e da tutto ciò che si collega a tale tematica. Come abbiamo dettagliatamente raccontato nei post delle scorse settimane, il margine del caos è stato scoperto empiricamente, osservando il comportamento e l’evoluzione degli automi cellulari, e ipotizzando che quanto valeva per tali sistemi, fosse vero anche per gli altri. È così che è stata formulata l’Ipotesi di Langton, su cui si basano le Classi di Wolfram-Langton; in modo analogo, studiando il comportamento dei sistemi reali alle prese con i problemi reali del loro ambiente, sono state scoperte altre leggi empiriche: la Legge di Corrispondenza, secondo cui, considerato un certo tipo di problema ambientale, i sistemi più idonei ad affrontarlo sono quelli che appartengono all’ordine di complessità corrispondente alla classe di complessità del problema considerato; e il Principio di Subottimalità, secondo cui i sistemi complessi non affrontano i problemi complessi trovando la soluzione migliore in assoluto, bensì individuando degli “ottimi locali”, ovvero soluzioni che sono sì le migliori, ma solo considerando porzioni circoscritte dello spazio delle soluzioni possibili. Tutte queste scoperte sono state fatte da ricercatori determinati a fondare una nuova disciplina, la scienza della complessità, intesa come studio empirico rigoroso dei sistemi complessi adattivi.
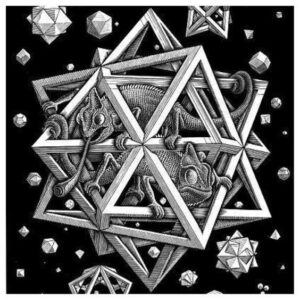 Veniamo al nucleo logico della complessità. Questo secondo nucleo è costituito dal Principio di Complementarietà. In questo caso, non si tratta di una scoperta empirica quanto piuttosto di una riflessione filosofica intorno al concetto stesso di “complessità”. Etimologicamente, mentre complicato è ciò che ha dei plichi, delle pieghe, e dunque può essere s-piegato, complesso è ciò che ha dei plessi, dunque degli intrecci, dei grovigli, che rimandano a qualcosa impossibile da s-piegare. Edgar Morin ha riformulato la presenza di tali plessi in termini di multidimensionalità. Detto nel modo più semplice possibile, complesso è tutto ciò che, per essere compreso, va necessariamente guardato da punti di vista diversi, ovvero considerando diverse dimensioni o fattori. Non solo: ciò che si osserva da una prospettiva, o considerando un certo fattore, può apparire in contraddizione con ciò che si osserva da altri punti di vista, o considerando altri fattori. In realtà non c’è alcuna “vera” contraddizione: il Principio di non contraddizione è sempre valido, solo che vale esclusivamente entro ciascuna dimensione; non ha alcun senso e alcuna validità se applicato in modo trasversale. In altre parole, eventuali aspetti conflittuali si escludono a vicenda intra-dimensionalmente; sono invece complementari tra loro inter- e trans-dimensionalmente.
Veniamo al nucleo logico della complessità. Questo secondo nucleo è costituito dal Principio di Complementarietà. In questo caso, non si tratta di una scoperta empirica quanto piuttosto di una riflessione filosofica intorno al concetto stesso di “complessità”. Etimologicamente, mentre complicato è ciò che ha dei plichi, delle pieghe, e dunque può essere s-piegato, complesso è ciò che ha dei plessi, dunque degli intrecci, dei grovigli, che rimandano a qualcosa impossibile da s-piegare. Edgar Morin ha riformulato la presenza di tali plessi in termini di multidimensionalità. Detto nel modo più semplice possibile, complesso è tutto ciò che, per essere compreso, va necessariamente guardato da punti di vista diversi, ovvero considerando diverse dimensioni o fattori. Non solo: ciò che si osserva da una prospettiva, o considerando un certo fattore, può apparire in contraddizione con ciò che si osserva da altri punti di vista, o considerando altri fattori. In realtà non c’è alcuna “vera” contraddizione: il Principio di non contraddizione è sempre valido, solo che vale esclusivamente entro ciascuna dimensione; non ha alcun senso e alcuna validità se applicato in modo trasversale. In altre parole, eventuali aspetti conflittuali si escludono a vicenda intra-dimensionalmente; sono invece complementari tra loro inter- e trans-dimensionalmente.
Gran parte di ciò che hanno scoperto gli scienziati studiando i sistemi dinamici al margine del caos e tutte le principali riflessioni filosofiche per cui siamo debitori a Morin e agli altri epistemologi della complessità erano conoscenze più o meno consolidate già verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Sono passati più di trent’anni da allora. Dopo tutto questo tempo, pensare in termini di complessità e diffondere la teoria e la cultura della complessità, può ancora essere considerato un approccio necessario, o anche solo utile?
Ci sembra di poter rispondere di sì. Vediamo perché.
In questi tre decenni, sono stati pubblicati centinaia di libri dedicati ai sistemi complessi; sul web esistono migliaia di siti che si occupano di complessità; la complessità viene insegnata nei corsi di laurea di numerose facoltà universitarie; parole come “complessità”, “caos” e “resilienza” ed espressioni come “effetto farfalla” e “non linearità” sono entrate a far parte del nostro linguaggio quotidiano. Tuttavia, nonostante i tanti anni trascorsi avendo a disposizione sia la conoscenza del margine del caos, sia il Principio di Complementarietà, le conseguenze concrete di questo sapere non si vedono ancora. Non si vedono nei campi della psicologia e dell’educazione, che sono i campi che più ci interessa approfondire in questo blog. Ma non si vedono neppure nella società, nella politica, nell’economia. Perché diciamo questo?
 Perché dai due nuclei della complessità emerge l’immagine di un mondo in cui bisogna imparare a convivere con la contraddizione, nel quale quando si cambia prospettiva insorge il dubbio, un dubbio non eliminabile a meno che non si decida di guardare le cose col paraocchi; un mondo in cui bisogna imparare a vivere all’ombra del caos, costantemente sul bordo del precipizio, con la consapevolezza che un passo falso è sempre possibile, che non esistono certezze e che l’unico modo di allontanarsi dal pericolo sarebbe allontanarsi da ciò che rende la vita degna di essere vissuta: l’originalità, la creatività, le differenze, i cambiamenti e soprattutto la libertà.
Perché dai due nuclei della complessità emerge l’immagine di un mondo in cui bisogna imparare a convivere con la contraddizione, nel quale quando si cambia prospettiva insorge il dubbio, un dubbio non eliminabile a meno che non si decida di guardare le cose col paraocchi; un mondo in cui bisogna imparare a vivere all’ombra del caos, costantemente sul bordo del precipizio, con la consapevolezza che un passo falso è sempre possibile, che non esistono certezze e che l’unico modo di allontanarsi dal pericolo sarebbe allontanarsi da ciò che rende la vita degna di essere vissuta: l’originalità, la creatività, le differenze, i cambiamenti e soprattutto la libertà.
Prendere sul serio i due nuclei della complessità, interiorizzarli, in fin dei conti significherebbe semplicemente iniziare a essere coerenti con una simile visione del mondo. Purtroppo questo cambiamento non è ancora avvenuto. Potremmo forse dire che, se è innegabile che oggi si parli molto di complessità, non per questo viviamo e pensiamo coerentemente con i suoi due nuclei.
Oltre a modificare la nostra visione generale del mondo, i due nuclei della complessità hanno anche ricadute assai specifiche sulla nostra mentalità e sulla nostra società.
Tra le conseguenze specifiche delle scoperte empiriche fatte sui sistemi complessi potremmo ricordare, tanto per fare qualche esempio:
– L’impossibilità che un sistema goda contemporaneamente dei vantaggi dell’ordine e di quelli del margine del caos: a qualcosa si deve pur rinunciare; concretamente, questo significa tra l’altro che non ci si può aspettare che in una democrazia tutto funzioni in modo rigidamente ordinato come in una dittatura; ma, d’altra parte, in una dittatura non ci sarebbero gli aspetti positivi presenti nelle democrazie.
– Non esiste un regime dinamico privo di difetti: anche il margine del caos, benché efficace con i problemi complessi, non lo è con quelli complicati. Innumerevoli problemi sorgono quando ci si dimentica di questa legge empirica; un errore tipico – ma disastroso – è quello di rendere le organizzazioni sempre più complicate sperando che questo migliori la loro capacità di affrontare i problemi complessi: per esempio, questo accade quando vengono introdotte nuove norme di Legge per risolvere problemi sociali che richiederebbero invece cambiamenti culturali e valoriali.
– Sfortunatamente, l’unico modo di controllare un sistema è quello di ridurre la sua complessità; in altre parole, non si può controllare un sistema e contemporaneamente garantire alle sue componenti quella libertà necessaria per auto-organizzarsi; dunque il manager di un’azienda, o il leader di un team, devono scegliere tra accentrare e controllare, rendendo l’organizzazione ottusa ma facilmente governabile, o delegare e rischiare, rendendo l’organizzazione creativa ma imprevedibile. Analoga scelta è chiamata a fare ogni coppia genitoriale nel crescere i propri figli.
– Tutti i regimi dinamici, compresi i due più funzionali, cioè l’ordine e il margine del caos, sono provvisori. Così come un cristallo può andare in frantumi, il regime cristallizzato può volgersi nel suo opposto, il caos. Ma anche il caos può volgersi bruscamente nel suo opposto. L’ordine può spostarsi al margine del caos. Il margine del caos, infine, è come una sottile membrana tra ordine ed eccesso di disordine: è forse il regime più precario di tutti; eppure esistono molte buone ragioni per cui i sistemi tendono a collocarsi in quella zona; e lì evolvono, in un equilibrio instabile e dinamico, sempre tentati, da un lato, da una maggiore stabilità, e sempre a rischio di scivolare nel caos, d’altro lato. Se ci si ferma a pensare che uno dei tanti sistemi al margine del caos è la biosfera terrestre, si capisce come mai gli scienziati che studiano i sistemi complessi adattivi non si stanchino di raccomandare di non sottoporla a eccessive perturbazioni: una perturbazione di troppo, anche una sola, e la biosfera potrebbe subire una transizione verso una mortale rigidità o un altrettanto letale squilibrio.
– Le caratteristiche dinamiche dei sistemi, la loro precarietà e l’impossibilità di conoscere con certezza le conseguenze del nostro agire sui sistemi presenti nel nostro ambiente, portano alla conclusione secondo cui ogni azione che perturba i sistemi del nostro ambiente dovrebbe essere tenuta d’occhio come qualcosa che potrebbe sfuggirci di mano e, dunque, azioni che in caso di problemi non possano essere interrotte andrebbero sempre evitate; detto in altro modo, la possibilità e la capacità di modificare e riadattare i propri piani e le proprie strategie dovrebbero sempre prevalere sulla capacità di elaborare e progettare piani e strategie basati su previsioni a lungo termine. Questo vale nella vita di ciascuno di noi, in famiglia, quando si governa un’azienda o un paese.
Anche il Principio di Complementarietà ha ricadute importanti sulla nostra mentalità e la nostra cultura. Volendo fare qualche esempio:
– I concetti di ragione e torto, vero e falso, giusto e sbagliato, e molte altre coppie di concetti contrapposti andrebbero impiegati solo nelle situazioni più banali ed elementari; nella maggioranza delle situazioni reali, applicarli richiederebbe adottare rappresentazioni della realtà così semplificate da perdere ogni verosimiglianza.
– Rinunciare a utilizzare tali concetti comporta rifondare l’etica e la giustizia su basi diverse da quelle tradizionali; anche i concetti tradizionali di reo e vittima andrebbero ripensati evitando sia le banalizzazioni (il reo come male assoluto; la vittima che, solo in quanto tale, è automaticamente mondata da ogni responsabilità), sia i ribaltamenti di ruoli (giustificazione del reo, colpevolizzazione della vittima).
– Il concetto di multidimensionalità, così come viene usato in epistemologia, incontra i concetti di biodiversità, razionalità allargata e strategia mista ottimale, rispettivamente utilizzati da ecologisti, psicologi e studiosi della teoria dei giochi; tutti questi concetti esprimono l’idea che, in tutti i campi, la diversità sia una risorsa; principio, questo, che viene spesso ribadito come ideale etico verso cui tendere ma che certamente non viene ancora percepito come realistico nella nostra prassi quotidiana.
– In generale, tutte le ideologie appaiono come visioni riduttive e ipersemplificate che andrebbero abbandonate e superate; il problema delle ideologie è che suddividono il mondo tra amici (chi condivide l’ideologia del proprio gruppo) e nemici (chi non la condivide o, meglio, chi adotta l’ideologia opposta). Esempi di contrapposizioni ideologiche sono i numerosi casi di dinamica simmetrica che abbiamo davanti agli occhi quotidianamente, come quella tra sostenitori e oppositori del governo, quella tra favorevoli e contrari all’accoglienza dei migranti stranieri, tra sostenitori e oppositori di Salvini, tra sostenitori e oppositori dei vaccini, tra sostenitori e oppositori delle grandi opere (come la linea ferroviaria per i TAV), tra europeisti e antieuropeisti, e molte altre contrapposizioni simili. Attualmente persino l’uso della mascherina viene affrontato in modo ideologico (indossarla è di sinistra, non indossarla di destra).
– Più in generale, andrebbe superato il pensiero dicotomico, polarizzato, basato su stereotipi e “aut-aut”, utilizzato per esempio quando si ragiona in termini di famiglia o carriera; industria o ambiente; morale o politica; democrazia o efficienza; iperspecializzazione o interdisciplinarità; cultura scientifica o cultura umanistica; globalizzazione o decrescita; naturalmente esempi analoghi potrebbero riempire pagine e pagine. Un caso di polarizzazione dicotomica che ci sta molto a cuore, dati i temi del nostro blog, è quello dell’adolescenza: di che cosa hanno bisogno gli adolescenti odierni? Di più regole o di maggiore comprensione? Di un po’ di buona vecchia disciplina o di un approccio finalmente vicino alla clinica? Hanno davvero bisogno dei “no che aiutano a crescere” oppure i genitori devono elargire con fiducia copiosi “sì che aiutano a crescere”?
– Anche far coincidere un metodo o una comunità, con i suoi membri, è un ingiustificabile atto di riduzionismo; una classe e chi la rappresenta, benché chiaramente legati, non si identificano: si può credere nella Scienza, nel metodo scientifico, e allo stesso tempo credere nella fallibilità degli scienziati e dubitare di specifiche affermazioni fatte da alcuni di loro; in altre parole, si può credere negli scienziati quando sono in laboratorio a “fare gli scienziati” ma essere in disaccordo con certe loro opinioni espresse durante un dibattito, un’intervista o l’ennesimo talk show, anche quando loro stessi siano in buona fede convinti che tali idee derivino dalla loro attività scientifica.
– Analogamente, è una forma di riduzionismo quella di ricondurre concetti distinti gli uni agli altri, solo “per farla più semplice”; la conseguenza indesiderabile di questa forma di riduzionismo è quella di trovarsi imbrigliati in paradossi e contraddizioni: l’esempio che fa Morin è quello dell’apparente paradosso del nostro mondo iperconnesso, in cui è vero che tutti comunicano con tutti, ma in cui è altrettanto vero che ognuno si sente sempre più solo, né ascoltato, né compreso; in realtà non c’è alcuna autentica contraddizione: non bisogna confondere la quantità di comunicazione tra esseri umani con la qualità della comunicazione tra loro. Sono dimensioni distinte e complementari.
Queste sono solo alcune delle conseguenze che probabilmente riscontreremo se e quando i due nuclei della complessità entreranno a far parte del nostro bagaglio culturale. Poiché al momento non ne fanno ancora parte, riteniamo abbia ancora un senso, dopo più di trent’anni, promuovere la cultura della complessità e il pensiero basato sulla complessità.